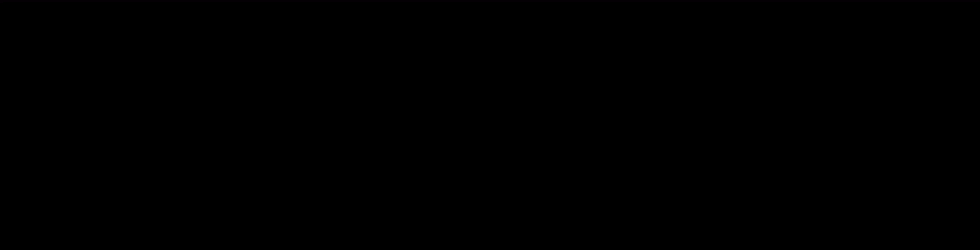Taranto: I Carabinieri della Compagnia di Taranto arrestano tre soggetti per detenzione e spaccio di cocaina

Prosegue senza tregua l’azione di contrasto al traffico di droga nell’ambito cittadino messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Taranto, al fine di rafforzare la sicurezza percepita nella borgata storica. Questa volta a finire sotto la lente d’ingrandimento del personale della Sezione Operativa è stata un’abitazione di via Cava 68, sita nella Città Vecchia di Taranto e utilizzata come laboratorio per il confezionamento e la successiva vendita di cocaina, che avveniva attraverso una delle finestre di un appartamento ubicato al primo piano di uno stabile, mediante un cesto che, all’occorrenza veniva sceso giù con una corda con all’interno le dosi di stupefacente. Nella circostanza, è stato approntato un dispositivo cui hanno preso parte anche unità cinofila antidroga dei Carabinieri di “Modugno” e personale dello Squadrone “Cacciatori” Carabinieri “Puglia”. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita a carico delle persone che occupavano l’appartamento, (un 56enne, già noto alle forze di polizia per diversi precedenti penali, un 54enne ed una 46enne entrambi incensurati) venivano rinvenuti grammi 40 di cocaina – in parte in forma solida e in parte già suddivisa in dosi – nonché materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione e la somma di € 736,00 quale provento dell’attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. L’appartamento era inoltre provvisto di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, per eludere gli eventuali controlli di polizia, che è stato anch’esso sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, le tre persone arrestate, su disposizione del P.M. di turno, sono state sottoposte agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. jonica mentre, la sostanza stupefacente rinvenuta sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, per accertarne l’esatta quantità ed il principio attivo.
PugliaPress
Quotidiano cartaceo e online dal 7 dicembre del 2000
redazione@pugliapress.it
direttore@pugliapress.it